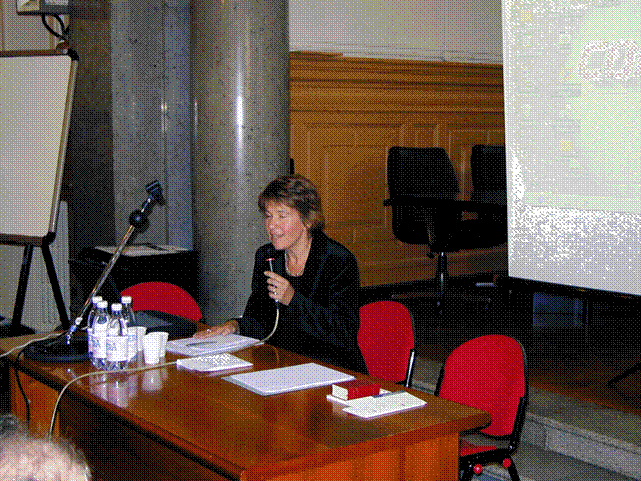
Daniela Picamus
Aspetti della ricezione del Petrarca negli adolescenti d’oggi
Vorrei iniziare con un apprezzamento sui
promotori dell’odierno convegno: i Dipartimenti accademici, ma soprattutto il
Laboratorio per la Didattica della Letteratura italiana, che, nato all’interno
dell’università, vuole proporsi come tramite tra la ricerca letteraria e la
didattica della letteratura.
Mi pare una buona iniziativa
per rivitalizzare un dialogo che, negli anni, si è
forse perso dietro i rispettivi tecnicismi – di ambito accademico e di ambito
scolastico – ma che, nel quadro dell’attuale scuola dell’autonomia e della
formazione specialistica degli insegnanti – in virtú delle attuali SSIS o, in
futuro, di altri percorsi formativi – trova la sua piú legittima collocazione.
Auspico cioè, assieme ai promotori, che questo
Laboratorio possa concretizzarsi e animarsi del contributo di docenti
dell’università e della scuola al fine di favorire sia il confronto fra la
ricerca accademica e quella didattica, sia la conseguente progettazione
di nuove attività in ambito scolastico.
Il convegno di oggi,
e segnatamente i diversi relatori qui invitati, mi sembrano testimoniare tale
volontà di dialogo.
E in un’ottica laboratoriale si pone lo stesso
programma del convegno, che vuole offrire, attraverso i diversi contributi,
nuovi spunti anche di tipo didattico.
Accanto ad argomenti tradizionali
dell’insegnamento letterario legato a Petrarca (la poesia, la lingua, il
sonetto proemiale) trovo interessanti aperture negli
interventi che pongono l’accento sulle interpretazioni di Petrarca ad opera di altri classici (Foscolo e Leopardi) o che
proiettano Petrarca nella poesia novecentesca, in generale, e di Saba e Ungaretti in particolare.
Anche la presenza di Petrarca nei siti Internet si pone come lettura “attuale”,
di interesse soprattutto per gli studenti.
A legarli insieme, i vari interventi
lasciano cioè trasparire la “permanenza” di Petrarca
anche nell’ambito della letteratura contemporanea, la sua intramontata
valenza, a settecento anni dalla nascita.
Il programma del convegno mi sembra
pertanto suggerire interessanti spunti didattici di cui, credo, molti docenti
potranno giovarsi per integrare o rinnovare l’approccio a
un “contenuto” cosí importante quale è Petrarca nel programma di italiano.
All’interno di questo quadro la mia è la
prima voce dal mondo della scuola nel suo complesso.
Non parlo solo a livello personale: mi
faccio infatti portavoce anche della componente
studenti, che, dell’insegnamento, rimangono i destinatari privilegiati.
Parlare della “modernità” di Petrarca è
luogo tradizionale nell’insegnamento della letteratura: modernità di poeta, di uomo, di studioso, di intellettuale. è di questo che parliamo ai nostri
studenti e che vogliamo loro trasmettere, affinché diventi un loro patrimonio
culturale. Che cosa avviene però in realtà? Come viene recepito il nostro insegnamento?
Cosa diventa Petrarca, una volta consegnato agli studenti?
È possibile capire che cosa questo auctor significhi
nella vita degli adolescenti del nuovo millennio? Raccogliere il loro giudizio?
Ho cercato di approfondire qual è la ricezione
di Petrarca nei giovani d’oggi attraverso l’esame di due gruppi di elaborati: il primo comprendeva prove di verifica di
alcune classi terze, che ho potuto visionare grazie alla generosa disponibilità
di alcune colleghe;
un secondo gruppo riguardava elaborati dei miei studenti di quinta, classe in
cui dovrebbe essere possibile, sulla base degli studi compiuti, effettuare con
maggior competenza opportuni confronti tra autori anche di epoche diverse.
Delle prove, che si presentavano di diversa
tipologia,
ho preso in considerazione soprattutto le affermazioni piú generali, quelle che
potevano suggerire elementi di “permanenza” (permanenti per lo studente)
relativi alla poetica e alla figura di Petrarca.
L’esame degli elaborati consente di
ricostruire i vari “volti" che Petrarca assume per gli studenti, e
l’originalità, talvolta, con cui a loro il Poeta si rivela.
Petrarca è, per voce quasi unanime, un
intellettuale moderno.
P. è riconosciuto come
un intellettuale nuovo per i suoi tempi. È nuova la sua posizione “sociale”.
Ha una visione del
mondo cosmopolita…è molto poco legato alle realtà
municipali…in piú getta le basi dell’umanesimo interessandosi grandemente dei
classici latini…nuova è anche
la sua figura di letterato-ambasciatore, una figura apprezzata a livello
europeo che gli consente di porsi come mediatore.
P., avendo preso gli ordini sacri, è economicamente
indipendente, cosa che gli consente di dedicarsi totalmente alla sua poesia.
Quello che piú lo distingue dagli altri poeti contemporanei
è il suo amore per la cultura classica. P. non è d’accordo con la normale
interpretazione della cultura antica: secondo lui dev’essere
considerata come cultura a sé stante, e non inferiore per la sua “paganità”.
P. non ha una patria fissa, è un
cosmopolita. Non sceglie quindi un pubblico circoscritto, ma molto ampio e
questo influenza molto i suoi scritti. Anche a questo è
dovuta la grande attenzione e la continua revisione di ciò che scrive:
vuole che i suoi componimenti siano perfetti anche per il suo pubblico.
È nuova la sua posizione “letteraria”:
Ma non meno importante
innovazione fu il rinnovamento dei temi letterari. Per la prima volta, nelle
sue poesie compare, accanto alla bellezza della donna, un contrasto interiore
tra il desiderio di gloria terrena e il bisogno di solitudine e pace
dell’anima. La stessa “donna angelo” acquisisce caratteristiche piú umane
rispetto alle donne dei poeti stilnovistici e sembra
coinvolgere di piú, fuori della finzione letteraria, il poeta.
L’uomo nuovo, politicamente impegnato
per il rinnovamento e lo svecchiamento della cultura non sembra però essere il
tratto destinato a permanere nell’enciclopedia personale dello studente. Di
fronte alla richiesta di un bilancio personale su ciò che Petrarca gli ha detto
o dato sono l’introspezione e l’interiorità gli aspetti che risultano meglio
aderenti alla personalità degli attuali adolescenti.
Credo che l’aspetto
dominante della poesia di Petrarca sia la malinconia, il segno di una
sensibilità che lo portò a trascorrere tutta la vita da uno stato di euforia a uno stato di prostrazione, da momenti di
entusiasmo a intervalli di depressione; tanto da far diventare triste, ma nello
steso tempo moderna la nota dominante del carattere petrarchesco.
In P. scopriamo con
meraviglia l’ansia e il tormento dell’uomo moderno.
Anche l’amore è un
tema molto attuale, che non è piú, come per Dante, il mezzo che serve a
congiungere l’uomo a Dio, ma è un mondo di sensazioni contrapposte (…)
La modernità di P. sta
nel suo carattere, nella presenza nella sua poesia di diversi e contrapposti
stati d’animo.
Lo studente tende, cioè,
a recuperare aspetti caratteriali, che tanto piú valgono quanto piú consentono
un’identificazione personale, un riconoscimento di tratti del proprio
carattere.
Questo scrittore (…) è riuscito a trasmettermi una miriade
di emozioni. Inquietudine, tristezza ma anche
tranquillità e patriottismo. Quello che però mi ha colpito maggiormente non è
stata la quantità ma la qualità delle sensazioni, il come è
riuscito a farle penetrare nel mio cuore. Il suo non è stato un attacco diretto
ma, piano piano, prima mi si è avvicinato, poi mi ha
avvolto nella sua magia e da allora mi ha definitivamente rapita:
è come una leggera brezza che poi si trasforma in tempesta. P. è un uomo che
soffre, ma che non impone nulla al lettore: scrivendo egli cerca di liberare il
proprio spirito dai sentimenti contrastanti che vivono in lui, sperando magari
di trovare piú chiarezza. è un
po’ lo stesso che faccio io: scrivo per sfogarmi. (…) è la dolcezza con cui P. si esprime che mi affascina di piú e
che lo rende unico: una caratteristica abbastanza rara, soprattutto negli
uomini.
In alcuni sonetti P. trasmette la solitudine e il disagio tipici
della mia generazione e, proprio per questo, molto vicini alla mia realtà
quotidiana. (…) Mi sono subito identificata nella descrizione che P. fa di sé.
Una persona che fugge dagli altri e si rifugia dove il resto degli uomini non
può raggiungerlo (per P. questo è rappresentato dalla natura; nel mio caso
invece è, di solito, un libro). Penso che P. sia molto piú attuale di tanti
altri, magari piú vicini a noi dal punto di vista cronologico, ma molto lontani
per quanto riguarda i temi trattati.
Le emozioni che ho avuto leggendo i testi di P. sono indescrivibili. Il suo amore per Laura, il suo
patriottismo, l’inquietudine in alcune poesie e la tranquillità in altre vengono fatti comprendere appieno dal poeta che ha la
capacità di trasmettere forti sensazioni attraverso lo scrivere. I componimenti
che mi hanno colpito di piú sono quelli d’amore per Laura che alcune volte sono
riusciti anche a farmi piangere. L’amore del poeta per
questa donna è infinito e Francesco riesce a trattarlo anche in maniera
attuale. A differenza di Dante, infatti, suo contemporaneo, egli non vede
l’amata come mezzo che serve a congiungere l’uomo a Dio, ma come un qualcosa
che gli trasmette un certo tipo di emozioni che
analizza e studia: si passa dalla gioia alla tristezza, dalla tristezza alla
disperazione, dal dolore all’entusiasmo(..) ciò mi fa pensare al suo grande
travaglio interiore.
Amore che
talvolta viene animosamente contestato
Non mi piacciono, né
lui né i suoi testi. Penso semplicemente che è noioso, troppo moralista. (…) Come è pesante l’amore di Dante per Beatrice, lo è quello di
P. per Laura. L’ossessionante passione verso una donna angelo, quasi divina, mi
attirava se era il soggetto di uno o due testi, ma
quando questo tema si è rivelato quello predominante, ha perduto il fascino che
gli attribuivo. (…) La sola cosa che ho trovato coinvolgente è stata la critica
alla corruzione della chiesa.
Personalmente trovo le poesie amorose del P. un po’ troppo
portate al lamento. Trovo eccessivo il rammarico e la disperazione che il poeta
esprime per il mancato amore di Laura e trovo patetico il suo “pentersi” per l’amore che prova. P. ha una visione
dell’amore totalmente opposta alla mia (perché) esprime una visione distruttiva
dell’amore mentre, secondo la mia opinione, l’amore è in grado di innalzare
l’animo delle persone innamorate.
Si contraddistingue (pur prendendo elementi da Dante) per
i suoi componimenti studiatissimi e per la forte simbologia usati.
Quando P. parla di
Laura, è molto moderato e attento nei termini; i suoi sentimenti non sono
urlati, ma freddamente e precisamente descritti, e nonostante ciò sono irruenti e passionali. Inoltre
Laura non ha la funzione salvatrice che ha la donna dello stilnovo.
E a distanza di anni,
gli studenti direbbero le stesse cose? Cosa rimane
di Petrarca?
Ho avuto l’opportunità di sottoporre un
confronto tra Petrarca e Leopardi alla mia quinta, quest’anno.
Ho chiesto quale dei due poeti sentissero piú vicino,
se individuassero modernità nei sentimenti da loro espressi.
Rimane l’amore il tema principe
tra quelli che vengono ricordati e nei quali lo
studente si riconosce, anche per la corporeità del sentimento petrarchesco.
Ci sono degli aspetti
di modernità nell’amore di P. poiché esso è un
sentimento che coinvolge totalmente il poeta, cosí come coinvolge totalmente
anche ai giorni nostri tutte le persone innamorate.
Infatti egli, coi suoi problemi amorosi si aggiudica una
gran modernità, almeno dal mio punto di vista. Basti ascoltare qualche
canzonetta dei nostri giorni: per lo piú tratterà di amore e delusioni date da donne poco
interessate. (…) Vedo piú attuale la poesia petrarchesca, perché limitata,
forse, ad un unico dolore, che è l’amore, sentimento molto ricorrente in questi
anni.
Nel pensiero di P.
ritengo ci siano elementi moderni presenti nel suo amore sofferto per Laura –
il dolore causato dall’amore rimane sempre attuale – ma soprattutto nella maggior
fisicità e concretezza del suo amore, che è di certo piú terreno rispetto ai
poeti che lo hanno preceduto. D’altra parte l’amore ai nostri giorni si
manifesta nella sua forma piú terrena e lascia poco spazio ad un sentimento
solo “mentale” ed interiorizzato simile a quello platonico.
Nel P. di moderno c’è
la sofferenza dell’amore che tanto spesso accompagna l’uomo: forse però nel P.
c’è il senso della peccaminosità dell’amore mondano che noi non abbiamo piú.
E Petrarca è soprattutto un uomo che soffre:
La sofferenza di P. è piú una sofferenza amorosa per la
donna amata, Laura… che viene sopportata grazie a “una
concezione religiosa della vita” e al “bisogno della spiritualità”.
La sua sofferenza viene
spesso capita e condivisa:
Mi ritrovo nella sua
concezione che riguarda la sofferenza per amore.
Condivido la sua
visione pessimistica dell’amore, legato alla sofferenza.
Mi sento vicina a
Petrarca perché mi è capitato di trovarmi nella sua stessa situazione:
invidiavo le persone che riuscivano ad addormentarsi
senza fatica, mentre io mi perdevo nei pensieri senza riuscire a trovare
tranquillità.
… ma anche
contestata:
Non riesco a
comprendere quest’infinita sofferenza per un amore
non corrisposto, in quanto l’amata non è l’unica donna
sulla terra.
… con le dovute distanze:
Dal mio punto di vista
non c’è modernità nei sentimenti espressi perché lo stile è cambiato: si scrive
ancora d’amore ma questo non viene piú inteso come una sofferenza alla quale
non c’è rimedio; ora l’amore è un sentimento stupendo della condizione umana.
In generale nel confronto Petrarca -
Leopardi è emersa una certa difficoltà a condividere il sistema filosofico
leopardiano.
A rischio di sembrare superficiale, mi trovo molto piú vicina a P.: il suo è un tema attuale (l’amore)
che prima o poi tutti sperimentano su sé stessi e io non rappresento certo
un’eccezione. Il sentimento petrarchesco è qualcosa di già provato e ciò
facilita l’avvicinamento alle composizioni del poeta. Leopardi è invece piú
filosofo e, anche se il suo tema risulta attuale e
addirittura infinito (nessuno può dare delle risposte ai suoi interrogativi),
egli è molto lontano da ciò che mi succede abitualmente e quindi i suoi
ragionamenti mi risultano troppo filosofici.
In alcuni casi, però, esso sembra
rispondere a una condizione individuale:
Io sono una persona pessimista, sempre e comunque non posso vedere il mondo in buona luce. Ciò che mi
accade, la maggior parte delle volte, lo reputo disastroso, di certo non piacevole.
Devo dire che sento molto piú vicino Leopardi, perché
vede problemi e sofferenze ovunque. Il pessimismo e la tristezza straripano
dalle sue opere.
Sento piú vicino a me
Leopardi, perché la sua visione cosí desolata della vita è estremamente
moderna e si è diffusa soprattutto nel ’900 (il male di vivere).
… o giovanile
in generale:
Egli infatti parla di come le
speranze giovanili svaniscano con il raggiungimento dell’età adulta. Parla di
pessimismo, un sentimento ormai molto diffuso nei giovani ma che io
personalmente non condivido né approvo.
Anche qui c’è chi ha saputo imporre drasticamente la sua voce critica:
Né l’idea di Petrarca dell’amore né di Leopardi
della vita mi corrispondono. Poiché non credo
nell’amore e non credo neanche che la vita sia solo sofferenza.
Agli alunni di quinta ho chiesto anche
un confronto sul lessico usato dai entrambi gli
autori.
Sono stati correttamente individuati
alcuni termini: noia, amore, dolore, affanno, riposo, ma le motivazioni sono
rimaste circoscritte all’ambito di ciascun autore; dell’affanno, ad esempio,
non è stato colto il significato piú ampio che Leopardi attribuisce alla
parola.
A questo punto proviamo a fare un bilancio.
Possiamo dirci soddisfatti dei
risultati? Per quanto mi riguarda, soltanto in parte.
Mi pare che sia rimasto l’uomo e che sia
sfumato il poeta. Mi spiego. Gli studenti delle terze sono riusciti a proporre
un quadro abbastanza completo del ruolo di Petrarca come intellettuale moderno;
hanno riportato correttamente e in modo vario i temi della sua poetica, laddove
gli studenti di quinta hanno ridotto all’aspetto amoroso la produzione
petrarchesca. Quella che mi sembra, però, mancare, in entrambi i gruppi, è la
sensibilità per la parola poetica: nessuno ha menzionato il labor limae, nessuno ha parlato dei
rifacimenti del Canzoniere, tesi
anche a perfezionare lo stile della sua poesia.
Il convegno di oggi
ribadisce come Petrarca sia figura “nodale” nello studio della letteratura, dal
Trecento in poi. Petrarca è auctor, che lega tanta parte della produzione letteraria:
passa attraverso Boiardo, Ariosto, Tasso, Della Casa,
alimenta il petrarchismo quattro e cinquecentesco nelle sue varie articolazioni
– bembesco e cortigiano per Segre,
eretico e ortodosso per Mengaldo, per citare alcune
delle classificazioni recepite dai manuali scolastici. Petrarca arriva fino al ’900 – a Ungaretti e Saba, ma anche a D’Annunzio, come si dirà in questi giorni e come un
manuale di recente pubblicazione puntualizza.
Non possiamo però accontentarci, come vorrebbero i nostri studenti, di ridurre
tale continuità alla tematica amorosa. Se questo è ciò che
resta agli studenti, forse è il caso di ricalibrare,
dosare diversamente, i contenuti del nostro insegnamento. Maggiore
spazio, secondo me, andrebbe dato all’importanza della lingua di Petrarca e
della sua influenza sulla storia della lingua, come altri interventi dopo il
mio approfondiranno.
Una maggiore attenzione agli aspetti
stilistici, nell’allenamento all’analisi, all’individuazione di
analogie e differenze, nel riconoscimento di aspetti linguistici e
retorici – una retorica nella quale confluiscano anche aspetti tematici e
ideologici
– potrebbe forse dotare gli studenti di quegli strumenti indispensabili per
renderli capaci di costruire un proprio autonomo e piú motivato giudizio.
Forse varrebbe la pena di concentrare
gli sforzi a partire dal volgare, che gli studenti comunque
intendono come lingua straniera (la parafrasi spesso viene intesa come
traduzione). Forse insistendo su una prospettiva diacronica di sviluppo della
parola poetica anche gli studenti riuscirebbero a dare il giusto peso, ad
esempio, alla sabiana rima fiore‑amore. Sono evidentemente, ipotesi di lavoro.
Speriamo solo che le imminenti
Indicazioni Nazionali, nella formulazione di conoscenze e abilità per la scuola
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, non limitino troppo la nostra libertà di insegnamento.
Daniela Picamus