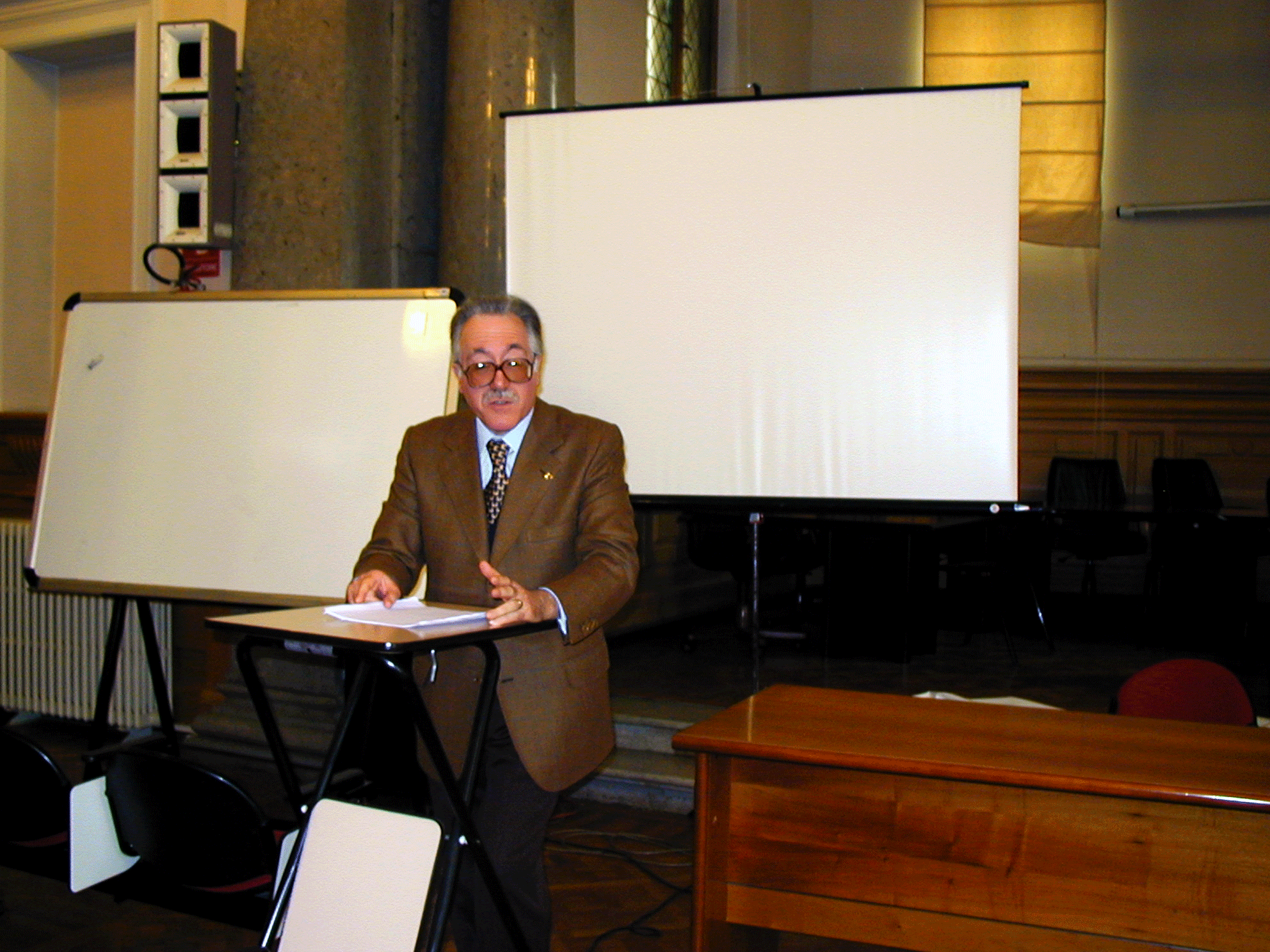
Fabio Cossutta
Pietro Bembo, o la riuscita di un’operazione “politicamente” corretta
L’evoluzione imposta al corso delle nostre lettere dalle teorie
del Bembo è cosa nota, ampiamente valutata e discussa. Si riconosce quanto gli
intellettuali italiani ad essa si siano adeguati, per ragioni di “grammatica”,
di “stile”,
di necessità politica – quella stessa che avrebbe portato «gran meraviglia poi
e dispetto» ai «critici romantici»
–, in taluni casi persino si adombra la convenienza di operare una sorta di
unificazione del «mercato librario»
del tempo. Nessuno avanza dubbi o riserve sull’accettazione dei principî
bembiani,
semmai si dibatte sul valore delle opinioni e posizioni diverse, rilevandone
volta a volta le manchevolezze o le incongruenze, nella maggioranza dei casi
attribuendo al patrizio e letterato veneto quell’autorevolezza morale e
spirituale che si sarebbe di riflesso trasferita a quanto egli veniva delineando
e realizzando:
in breve, l’auctoritas dell’uomo
avrebbe trascinato seco, nella dovuta sfera di prestigio e fascino, il senso
stesso della sua proposta.
Su tutto questo pare a me non esserci spazio a discussione
alcuna. Tuttavia, poiché si è storicamente verificata una contesa, alla fine
della quale uno è risultato vincitore
assoluto, ed è stato riconosciuto tale per i successivi tre secoli, lungi dal
voler rivisitare tutto il dibattito fin qui intercorso e che ancora è destinato
a seguitare, varrebbe piuttosto la pena soffermarsi su alcuni punti problematici,
su alcuni punti interrogativi rimasti aperti, e sui quali si tenterà di
abbozzare una risposta.
È ben vero che la questione della lingua aveva incominciato ad
essere impostata (teoricamente parlando) dagli umanisti e aveva trovato poi
sbocco nelle grandi – e contrapposte – teorizzazioni rinascimentali;
tuttavia non mi pare sufficiente – a capire e inquadrare correttamente le posizioni
in campo – il ricorso al principio d’autorità, né applicandolo alla personalità
del bembo, né invocandolo come
bisogno “primario” delle corti “imbolsite” nell’Italia devastata dagli
stranieri eserciti,
né proiettandolo come strumento principe della successiva Controriforma.
Insomma, detto in breve, non riesco a convincermi che il primato di Petrarca
dovesse “necessariamente” comportare la conseguente esclusione di Dante, né che
tale esclusione fosse dovuta al “gusto” di messer Pietro, e neppure che la
prima (quella che noi dopo Foscolo e i romantici abbiamo recuperato come tale)
Corona fiorentina costituisse insopportabile zavorra per i conformismi
controriformistici,
proprio quando una ampia proiezione nell’aldilà sarebbe stata vista soltanto
con favore.
E in effetti, se si va a ripercorrere l’iter della questione, si vede che i letterati umanisti, sia pur
disputando ciceronianamente pro e contro, finivano poi per riconoscere la
paritaria eccellenza di tutti e tre quei grandi del Trecento, ed il Bembo solo
a un certo punto muta rotta e propende per una decisa potatura, vittima della
quale rimane il povero Dante, nonostante le amorevoli cure prestategli a inizio
secolo. Conversione sulla via di Damasco? Affinamento della propria coscienza
“stilistica”? Parrebbe di sí, o, almeno, questa è l’opinione dominante nella
critica, che non per caso può trovare giustificazione e appoggio nel gusto
“neomedievale” e “neobarbarico” dell’Ottocento romantico, se non fosse che il
Foscolo, iniziatore della svolta, tutto può essere definito tranne che ostile
ai “classici”, quei classici che avevano trovato proprio in Petrarca l’aedo
principe. E non credo neppure che in Bembo sia maturata dopo gli Asolani una coscienza “grammaticale”
evoluta al punto da imporgli un aut aut:
fuori Dante come «fuori i barbari»; non ci credo perché è opinione corrente del
tempo – condivisa sia da Bembo sia da Castiglione – che il primato della
“lingua” sia determinato non da peculiarità intrinseche, bensí da coloro che,
esprimendosi al meglio, hanno fatto di tale lingua il proprio eccelso e sublime
vettore. Cosí si esprime il Magnifico Giuliano nelle Prose, quando afferma che non esiste lingua degna di considerazione
senza scrittori che ne diano testimonianza;
di tenore analogo sono le conclusioni a cui si perviene dopo una certa
schermaglia nel Cortegiano, là dove
Ludovico da Canossa e Federico Fregoso contendono un po’ sull’imitazione – e
risulta perdente il Fregoso, vicino alla posizione “rigida” del Bembo, mentre
prevale il Canossa, portavoce di quell’elasticità cara al Castiglione – ma si
ritrovano a condividere talune questioni di principio. Per esempio che non sono
le parole antiche a rendere uno
scritto degno o non degno, ma è il pensiero
in esso contenuto a farne la forza, con la conseguenza che scindere i contenuti
dalla loro espressione costituirebbe operazione priva di senno e di senso;
ancora, rifacendosi ai grandi “esemplari” modelli dell’antichità, e schierando
in campo esempi illustri di scrittori “impuri” epperò immensi nelle opere
lasciate (come Livio e la sua “patavinitas”),
si ribadisce il principio che dottrina, esperienza e ricchezza d’ingegno fanno
grande una lingua, e non l’opposto, e si rileva come tutte le piú geniali
“invenzioni” stilistiche nascano da innovazioni, ossia “violazioni” della norma
(«abusioni dalle regule
grammaticali»), che alla fine, grazie ai valori trasmessi, vengono
sentite come “piacevoli”, accettate e inserite nella regola.
Per un trattato che mira a costruire una figura di perfetto “gentiluomo”, privo
affatto di spigoli e asperità, affermazioni di questo genere appaiono rilevanti
assai, anche perché, ad osservarle in controluce, esse non inquinano affatto il
principio dell’armonia e della possibile “uniformità”: si limitano – in
concordia col Bembo – a privilegiare il “pensiero” sulla “parola”, la catena di
concetti sulla sintassi che li esprime, i “valori” veicolati sul “veicolo” che
li trasporta. Se piú “parco” è il Bembo sull’argomento, non è però egli per
nulla distante in via di principio, tant’è vero che Giuliano de’ Medici, nel
passaggio sopra citato, aggiunge, nel difendere la sua lingua fiorentina regolata
contro la lingua “cortigiana” del Calmeta,
che potrebbe a sua difesa portare l’esempio dei suoi «due Toschi», che sarebbero Petrarca e Boccaccio,
contro i quali non potrebbe schierarsi campione alcuno che abbia prodotto testi;
che è poi il riproporre quanto l’Autore stesso aveva, en passant, ragionato nella dedica al cardinale Giulio de’ Medici
(il futuro papa Clemente VII), quando aveva affermato che le leggi della lingua
che si vanno cercando traggono origine dalla città di Firenze
e dai suoi scrittori, e tale robusto e inossidabile principio sarebbe stato ripreso
proprio dal portavoce primo di Pietro, cioè il fratello Carlo, il quale, nello
spiegare ad Ercole Strozza la superiorità della lingua fiorentina anche su
quella veneziana, porta come argomento (al di là di un certo gusto e una certa
sensibilità che egli prova verso il toscano, gusto e sensibilità affinati ed
educati dalla “lettura”) sostanzialmente la carenza
di autori veneti
e, dall’altra parte, la gran copia di scrittori toscani, i quali hanno
costruito nel tempo la regola e la gentilezza
di quella lingua (letteraria). E, del
resto, le lingue sono piú o meno belle e buone a seconda del valore degli
scrittori che di esse si sono serviti per lasciare al mondo le loro
testimonianze, e pertanto la lingua fiorentina, da cosí tante celebrità
supportata, può senza fallo essere riconosciuta come superiore a tutti gli
altri volgari. Sottolinea rispondendo lo Strozza – rivolto al Magnifico
Giuliano – che tale lode è particolarmente degna di nota, in quanto proviene da
un veneziano, persona di grande giudizio, ma pur sempre “straniera” rispetto a
Firenze; e Federigo Fregoso è subito pronto ad aggiungere che, a suo avviso,
anche i poeti veneziani si sono avvalsi della lingua fiorentina (non solo a
maggior gloria di essa ma, soprattutto, a inoppugnabile sostegno delle argomentazioni
prodotte).
Ed analoghi riferimenti possono essere riscontrati nel pur
dissidente Castiglione, laddove, giustificando la propria scelta della lingua,
spiega di non avere imitato il Boccaccio, e neppure usato il toscano al tempo
parlato, perché, oltre al fatto che si sarebbe eventualmente trattato di
imitazione impropria – avendo il Boccaccio scritto novelle ed essendo invece in
fase di composizione un trattato –, il parlar bene nasce soprattutto dall’uso,
vale a dire da una pratica viva. In
aggiunta, tra i tanti motivi (fra i quali: l’utilizzo di parole desuete
renderebbe l’opera meno praticabile) della propria scelta, va inserita inoltre
la considerazione in cui viene tenuta la lingua parlata nelle nobili città
dell’Italia, da persone ragguardevoli e colte, che la impiegano in alte cose,
come affari e imprese di stato, militari e diplomatiche;
né, a voler supporre che il toscano nobiliti vocaboli latini corrotti dal
tempo, si vede perché tale opera di nobilitazione non possa spettare altresí al
lombardo, nella misura in cui a sua volta perpetua certi latinismi;
per cui se il Boccaccio è stato imitato, ciò è avvenuto con misura, per quel
che si conviene, e assieme a lui altri autori ugualmente degni di stima sono
stati osservati come modelli di riferimento:
in fondo, è prova di sincerità ed onestà intellettuale presentare se stesso
come lombardo, cioè com’egli è, e non risulta nessun divieto o proibizione a
scrivere e parlare nella propria lingua. E se qui i punti di vista di quei due
grandi letterati del Rinascimento divergono – ma non al punto da scavare un
incolmabile fossato –, essi divergono (sobriamente e pacatamente) sulle linee
operative e propositive, non sul principio che in tanto esiste una lingua in
quanto ci sono persone che la parlano, e, al livello sommo, in quanto ci sono
grandi scrittori che la esaltano, e che, guadagnandosi sul campo gloria e fama,
diventano inevitabilmente punti di riferimento imprescindibili, a volte – come
può accadere nei costumi umani – persino con degli “eccessi”,
che, per essere riferiti a quel tempo, in cui la cultura non era ancora
inquinata dai mass-media, paiono a me significativi assai.
In definitiva, su un punto Castiglione e Bembo – per limitarmi
ai due maîtres à penser piú rilevanti
– convergono: prima vengono gli autori, poi le testimonianze scritte, da ultimo
le regole che contrassegnano una lingua ed uno stile – né si vede come potrebbe
esser diversamente, a meno di non voler forzare le cose per esigenze altre.
Sarebbe come chiedersi se viene prima la poesia o il poeta: mi pare logico che
sia il poeta a fare la poesia e non
viceversa, anche se trae linfa dalla frequentazione dei poeti suoi antecessori.
Qui, poi, si sta parlando di grandi
poeti, non di minori, e se togliamo ai grandi l’“originalità”, ossia la
capacità di creare e di “innovare”, non si vede di essi che resti. Per
conseguenza, se di lingua “letteraria” vogliamo parlare e della sua
“grammatica”, si dovrà ricorrere – per costruirla, o meglio, per ricostruirla –
ai “letterati” che l’hanno «usata» (per dirla con Castiglione), ovvero a coloro
che l’hanno, con le loro opere, portata a livelli sommi di espressività. E,
francamente, ove si voglia sostenere che Dante ha sempre forzato le regole
secondo la sua convenienza, che la lingua della letteratura non deve ricavare da
lui le regole che si cercano, mentre al contrario il Petrarca non solo ha
sempre osservato le regole, ma le ha anche applicate in maniera sottile ed
elegante,
non si capisce bene di quali “regole” («domine»!) si vada parlando, posto che,
se l’uno le ha osservate e l’altro le ha trasgredite, chi è il terzo che le ha
scritte?
Non è – questo – il solo punto in cui le argomentazioni del
Bembo offrano il fianco all’impugnazione. Si ripercorra rapidamente
l’itinerario in progress che porta a
fulminare il povero Dante con l’accusa di “ineleganza”. Carlo Bembo cita i
“famigerati” versi contenenti la parola «stregghia», la parola «scabbia» e la
parola «scardova»: meglio era il tacerle che il dirle, perché usare parole
«rozze e disonorate» umilia la poesia, e non è confacente a un livello
dignitoso scrivere la parola «biscazza»; Petrarca, al contrario, cercò sempre
di dire le cose nella maniera piú acconcia, decorosa ed elegante,
e se Dante e Cino rivelano taluni limiti, consistenti nel fatto di risultare
alle volte piacevoli senza essere gravi, oppure gravi senza essere piacevoli, solo
il Petrarca è riuscito a essere perfetto nel conciliare le due cose sempre.
Però piú avanti, non nelle immediatezze invero, viene citato come esempio di
«maravigliosa gravità»
il sonetto delle Rime in morte che
inizia con «Mentre che ’l cor dagli amorosi vermi / fu consumato», e bisognerà
pure chiedersi perché questo cuore, fatto pastura di larve e di lombrichi
banchettanti, appaia al Bembo meno sconveniente della «scardova» dantesca! Ma
soprattutto, che senso ha comparare luoghi dell’Inferno con le Rime? Che
senso ha mettere a confronto passaggi di poesia “comica”
con versi di poesia “tragica”, per concludere che sono piú “eleganti” i secondi?
Perché non azzarda il Bembo un paragone tra la finale Canzone alla Vergine dei Fragmenta
e la consimile invocazione alla Vergine, fatta da S. Bernardo nel XXXIII del Paradiso? Sarebbe sí pertinente, ma il
confronto si concluderebbe con un verdetto di parità.
Nemmeno appare del tutto fondata e dirimente la considerazione
– fatta dal fratello Carlo – che Dante ha voluto occuparsi di tutto, quindi di troppo,
e che il suo poema è un enorme campo, nel quale al grano è mescolata troppa
erba cattiva e sterile;
analoghi criteri di valutazione potrebbero essere applicati al Boccaccio, del
quale si accennano taluni limiti di “convenienza” e di “giudizio”, e tuttavia
il recupero globale avviene in nome dello stile buono e «leggiadro».
Ma si pensi – giusto per ricorrere ad un esempio – alla frequentatissima (da
noi almeno) novella di frate Cipolla, nella quale Guccio Imbratta, dopo aver
adocchiato la Nuta «grassa e grossa e piccola e mal fatta e con un paio di
poppe che parean due ceston da letame, e con un viso che parea de’ Baronci,
tutta sudata, unta e affumata»,
scende a lei «non altramenti che si gitta l’avoltoio alla carogna»: lo stile ci
sarà pure, ma è quello inesorabilmente “comico” che a tale racconto si addice.
Né la rassegna delle di lei venustà è compiuta, perché probabilmente il pezzo
forte (ammesso che il precedente possa in qualche modo esser considerato
“lieve”) trovasi nell’immediato prosieguo, dove – se mai ce ne fosse bisogno –
lo “scavo” nei particolari del disgusto continua, descrivendo, con la
sufficiente abbondanza, «un suo cappuccio, sopra il quale era tanto untume che
avrebbe condito il calderon d’Altopascio», «un suo farsetto rotto e ripezzato,
e intorno al collo e sotto le ditella smaltato di sudiciume, con più macchie e
di più colori che mai drappi fossero tartareschi o indiani», «le sue scarpette
tutte rotte», e «le calze sdrucite»: la sinergia di valori visivi, olfattivi e
tattili è compiuta, con il risultato di portarci – se leggiamo con la dovuta
riflessione – quasi al vomito. Ancora una volta vien da pensare alla famigerata
«scardova»: trovarcene una in quella specie di porcilaia che è la cucina di
quell’ostello! Forse la presenza di quel povero pesce avrebbe potuto
contribuire a trattenere i nostri conati! E, in ogni caso, al di là delle
battute, posto che anche in Boccaccio riscontriamo un’equilibrata alternanza di
livelli “alti” e di livelli “mezzani”, non si comprende bene perché ciò che si
scusa e copre in quest’ultimo (e che lo differenzia nettamente dal Petrarca)
non può trovare giustificazione alcuna per Dante, a meno che non si voglia del
tutto espungere dalla letteratura lo stile “comico”. Il che costituirebbe – lo
si comprende bene – pura follia. Né sarebbe in qualche modo accettabile il
poter nemmeno presumere che il Bembo fosse una specie di sprovveduto, malamente
addentro alle cose letterarie e ciabattante in cotal guisa.
Quella specie di attacco frontale portato a Dante può trovare –
a mio avviso – una prima giustificazione considerando quanto il pubblico rinascimentale
poteva leggere in Gian Francesco Fortunio. Le sue Regole grammaticali, pubblicate – con forte anticipo su tutti – ad
Ancona nel 1516, “prima volgare grammatica” secondo la dichiarazione
dell’Autore stesso,
risultarono – com’è noto – sempre ostiche al Bembo, che, vuoi per ragioni di
primato personale,
vuoi per altri piú fondati motivi, non riuscí mai ad accettarle. In esse
l’operazione di cernita eseguita sui testimoni letterari – al fine di ricavare
quelle “regole” che, appunto, solo una tradizione letteraria può dare – era
stata condotta in modo da creare una sorta di persuasiva equipollenza
stilistica tra il Petrarca e Dante, sia attraverso le affermazioni contenute
nel Proemio – dove si enuncia tranquillamente e si prende atto che tutti i
talenti d’Italia, di qualunque zona siano nativi, se vogliono comporre rime,
assorbono il piú possibile lo stile di Petrarca e di Dante,
e dunque con parole toscane verseggiano –, sia attraverso lo sgranarsi degli
esempi o testimonianze offerte volta per volta a corredo della sua esposizione
dei principî. è vero che il
Fortunio riconosce (se cosí si può dire) che della grammatica il Petrarca è stato
«diligentissimo osservatore»,
mentre a suo dire Dante è stato «molto nelle rime licenzioso»,
tuttavia non solo questo giudizio è, in certo senso, viziato da carenza di
sensibilità ritmica e da pressoché totale ignoranza del concetto di «licenza
poetica», ma anche quando si tratta di operare delle scelte, a favore o contro
l’uno o l’altro, sostanzialmente prevale in lui l’atteggiamento di sottomissione
all’auctoritas di quei due grandi
padri delle lettere italiane. Cosí, se su «fummo» e «fumo» opta per la scelta
scempia di Petrarca e critica invece le geminazioni dantesche,
in un altro caso, sempre discutendo di scempie e di geminate (Bacco, Baco)
porta gli esempi di Petrarca prima (Bacco) e di Dante poi (Baco), ma non decide
e rispetta paritariamente i due autori.
Vero è ben che tale rapporto “paritario” è per lo meno coonestato da scelte
stilistiche “pertinenti”, nel senso che egli cita non solo dall’Inferno, ma anche dal Purgatorio e dal Paradiso, e, inoltre, preleva materiale interessante anche dalla Vita Nuova e dal Convivio: insomma, se può, riesce ad attuare un confronto
appropriato di livelli stilistici, la qual cosa non poteva non avere il suo
peso nel confermare l’autorevolezza del modello dantesco, associato pari pari a
quello petrarchesco e boccacciano. Con tale precedente doveva il Bembo confrontarsi
nel 1525, anno della prima edizione a stampa delle Prose.
Ma noi sappiamo che una buona e rilevante parte dell’opera era
già composta e circolava manoscritta intorno al 1512-13, tant’è vero che ci è
rimasta una sua lettera che accompagna l’invio all’amico Trifone Gabriele di
copia dei primi due libri, con la quale lo prega di leggere criticamente quanto
finora composto,
segnalando senza risparmio tutti gli errori, e lo invita, inoltre, a non
trascriversi esemplare alcuno,
perché è arciconvinto che mutamenti e cambi saranno in continuazione apportati
in moltissimi passi. I fondamenti teorici sono impostati proprio nei primi due
libri, e quindi sarà lecito supporre che la questione “dantesca” fosse già
allora a lui presente, prima, quindi, che le Regole del Fortunio circolassero a stampa per l’Italia. E se dunque
fa dire al fratello Carlo che la lingua delle scritture non deve accostarsi a
quella del popolo,
sempre mutante e per giunta già assecondata dai dicitori di piazza e dai
menestrelli, a meno che sia in condizione di non perdere né gravità né
grandezza; che, in aggiunta, è ben piú importante riuscire a far giungere il
messaggio alle generazioni successive, senza curarsi di piacere ai
contemporanei e mettendoli tranquillamente in non cale, lavorando con questo per
l’eternità, o per lo meno in funzione del ricordo trasmesso ai secoli
successivi; e se, nel citare per la loro perfezione stilistica Omero, Virgilio,
Demostene, Cicerone – i quali sono stati certamente dal popolo capiti e intesi,
ma hanno sempre altresí ragionato in maniera personale ed eccelsa, sicuramente
non adagiandosi sulle voci popolari – associa ad essi Petrarca e Boccaccio, con
la precisazione che questi ultimi non hanno affatto ragionato con la testa o
con la bocca del popolo, si può tranquillamente assentire per il Petrarca, ma
non si può non ricordare, proprio a quest’ultimo proposito, che Chichibio parla
in veneziano, che Currado Gianfigliazzi, «nobile cittadino, liberale e
magnifico», nell’apostrofare il cuoco gli rivolge un secco «Che ti par, ghiottone?»
(e non si vede come altrimenti avrebbero dovuto esprimersi, non concedendo la
circostanza e il luogo occasione alcuna per un parlar “grave” o paludato), che,
infine, a tacer d’altro, anche «messer Geri Spina», nel momento in cui deve
semplicemente rivolgere una domanda all’oste che sta esibendo un «orcioletto
bolognese nuovo del suo buon vin bianco e due bicchieri che parevan d’ariento,
sí eran chiari», senza tanti fronzoli o preoccupazioni d’eleganza condecente al
suo status, gli si rivolge
direttamente con un «Chente è, Cisti? È buono?».
Dunque, a voler essere
obiettivi, pure in Boccaccio troviamo – e non possiamo non trovare – elementi
tratti dal linguaggio “parlato”, vale a dire stilemi pertinenti al livello
“comico”, in questi casi usati, forse, con stile buono e «leggiadro», e
tuttavia inespungibili dalla ricchezza complessiva del Decameron. Insomma, Bembo si guarda bene dall’indicare come modelli
solo 49 novelle, ed è tutta la raccolta a funzionare come exemplum, sia pure con quelle riserve che – a mio avviso – alludono
piuttosto a certi episodi “scandalosi” e sessualmente “licenziosi”; nondimeno
l’irritazione del patrizio veneziano si appunta – per Dante – su alcune parole
come «scardova», «biscazza» e «stregghia» che, fra l’altro, fino al Cinquecento
compaiono una sola volta nei testi letterari italiani (con l’eccezione di
«stregghia», la quale ricompare, non per caso, in Burchiello e Berni), e sono hapax in Dante stesso, e che dunque non
possono essere assolutamente considerate pietre di futuri scandali. Ma è, per
l’appunto, vera irritazione? E se
tale deve essere considerata, dove
andrebbe a finire la coerenza personale e la stessa struttura intellettuale del
Bembo, considerato il fatto che della debolezza di simili obiezioni lui per primo non poteva non rendersi conto?
Per la verità, a voler cercare con attenzione e sottigliezza
(soprattutto sottigliezza), qualche indizio significativo si trova: per
esempio, nel Prologo al II Libro,
in cui l’Autore stesso, rivolgendosi ancora una volta al cardinale Giulio,
riconosce l’eccellenza di Dante – definendolo incontestabilmente «grande e
magnifico poeta», che ha dato un contributo notevolissimo alla crescita del
volgare letterario, lasciandosi, e di molto, indietro gli altri. Se poi fu il
Petrarca a esprimere tutte le grazie della poesia volgare, e infine il
Boccaccio, che si rivelò nato per la prosa, e se dopo di questi due nessun altro è riuscito a toccare quei vertici, l’affermazione
viene certamente usata per vituperare il secolo presente
– nel quale pure la lingua latina è tornata a splendere come ai suoi aurei
tempi – e per invitare i contemporanei affinché scrivano in volgare, lingua
nella quale si ragiona, purché sia un volgare elegante ed alto, i cui supremi
punti di riferimento debbono essere costituiti esclusivamente da quelle due
corone fiorentine; tuttavia in questo passo la funzione “essenziale” e insieme
“monumentale” svolta da Dante non è affatto negata, né sottovalutata.
Trattasi però di un prologo, nel quale il Bembo parla direttamente al suo
dedicatario, mentre i punti salienti del dibattito, condotto dai personaggi che
si ritrovano a “questionare” nel palazzo patrizio di Venezia, su Dante
esprimono una condanna ed un distacco nettissimi. E allora? A quale dei due
Bembo si deve prestar fede? all’autore Pietro o al fratello Carlo (l’amatissimo
fratello Carlo pieno di attenzioni e di amore per Pietro,
che si prendeva carico di tutti gli affanni, e al diletto congiunto concedeva
cosí lo spazio e il tempo necessari per l’ambito ozio culturale), che in quella
costruzione letteraria assume la funzione di portavoce delle idee‑guida? E
Pietro, alla fin fine, costruisce presupposti ai quali aderisce con
convinzione, oppure vi si piega – pur essendone l’artefice – obtorto collo?
La questione non è semplice, ed è per di piú complicata dal
fatto che Bembo e Castiglione congiuntamente, i due maggiori trattatisti del
nostro Rinascimento (e, forse, non soltanto loro due), compiono la scelta di
esprimersi – pur mantenendo taluni dissensi – attraverso un parlare coperto. Ci sono delle lettere che testimoniano
la stima del Castiglione per il Bembo, e insieme le rinnovate richieste di un
giudizio sul Cortegiano,
nonché suggerimenti per emendarne gli eventuali errori. Ma c’è, soprattutto,
una grande affinità nell’affrontare – in entrambe le opere – i passaggi piú
spinosi e delicati, fra i quali si colloca proprio la questione della lingua.
Se può rinvenirsi, nelle Prose,
un passaggio apertamente polemico, esso è dedicato proprio alla teoria
“cortigiana” e al Calmeta che la propugna,
con vigorose contestazioni mosse tanto dal Magnifico Giuliano quanto da Trifone
Gabriele, pervenendo in fine alla conclusione secca che non solidi argomenti
sono quelli del Calmeta e di tutti coloro che sostengono simile tipo di lingua
come modello.
Piú “sinuosa” è la condotta di consimile disputa nel Cortegiano, anche perché
(o soprattutto perché) è proprio in direzione del Calmeta che Castiglione si
schiera, facendosi rappresentare da Ludovico da Canossa.
L’ideale di “misura” non può mai in nessun momento essere
tralasciato, e dunque se si vuol “ben” parlare, bisogna evitare sempre
l’affettazione, e fuggire il malo esempio di taluni Lombardi i quali, dopo un
breve periodo di soggiorno all’estero, acquisiscono l’abitudine di
inframmezzare nei loro discorsi parole ora romane, ora francesi, ora spagnole,
ora “altre”.
Quel che viene qui criticato è, ovviamente, l’eccesso, per cui ciò che dovrebbe
costituire piacevole “eccezione” diventa all’opposto sgradevole e pesante
“abitudine”; tuttavia Federico Fregoso oppone che, nel parlare, non sarebbe
forse buona cosa usare le parole toscane antiche, poiché sarebbe segno di
affettazione;
viceversa, nello scrivere, il loro uso sarebbe commendevole, poiché esse
darebbero agli scritti quell’autorità e quella gravità di cui ogni scritto abbisogna.
Obietta a sua volta il Conte che appare cosa ben bizzarra usare negli scritti
ciò che si evita nei parlati,
essendo la scrittura testimonianza di ciò che si ragiona e dice, la quale ha il
pregio di tramandarsi nel tempo (dunque – ciceronianamente – vita e memoria
delle parole): per questo motivo deve essere certamente piú limata e sorvegliata,
ma non al punto di discostarsi da quel che “effettualmente” si pensa e si
dichiara; si tratterà allora – ancora una volta – di selezionare le piú belle e rilevanti delle espressioni “in uso”,
tenendo però ben fermo che non deve esserci iato alcuno tra bel parlare e bello
scrivere. Pertanto sarebbe da lodare colui che, oltre a fuggire gli anacronismi
ormai desueti (cioè gli arcaismi “toscani”), impiegasse nella sua espressione,
scritta e parlata, le parole piú belle e piú graziose che hanno acquisito
diritto di cittadinanza e in Toscana e in altri luoghi della italica penisola.
Ribatte Federico che la lettura è, e deve essere, cosa impegnativa, per cui
qualche parola o passaggio difficile non solo non guasta, ma addirittura
stimola il lettore e lo mantiene sollecito nello sforzo di comprendere.
Ecco perché l’antico toscano è preferibile, in quanto è pregno di quella maestà
derivante dal tempo, e solo cosí si dona allo scritto la grazia e la
venerazione necessaria.
Aggiungasi che tante parti d’Italia sono, pur nella equivalente nobiltà loro,
tra loro diverse assai, e non sarebbe invece equivalente impiegare negli
scritti il bergamasco al posto del fiorentino! Meglio è dunque, a fugare ogni
dubbio, prendere il Petrarca e il Boccaccio come modelli
– e di Dante non si fa qui parola alcuna. Successivamente Ludovico, nel ribadire
la propria posizione, concede al toscano letterario i meriti che gli competono,
e aggiunge che tali meriti sono stati acquisiti per merito di tre nobili ingegni letterari, dei quali
menziona solo il Petrarca;
piú avanti precisa meglio il senso dell’eclettismo “moderato”,
e conclude ritenendo che Petrarca e Boccaccio, se fossero vivi, aggiornerebbero
la lingua usata nei loro scritti
(e sconsiglierebbero chi pedissequamente li imita): di nuovo compaiono le punte
di diamante del magistero letterario fiorentino, e il nome di Dante ancora una
volta non c’è. Il dissenso dalla
posizione del Bembo è tanto netto nella sostanza quanto attenuato negli
argomenti usati:
soprattutto c’è il silenzio su Dante,
che non è forse una rimozione, ma è
senza dubbio un segno di cautela. Per
altro, se Pietro è alquanto severo nel togliere valore alla contemporaneità,
invitandola a guardare al lontano passato
“imitandolo”, Baldassar, nel contestare la rigidità del principio “imitativo”,
considerato costrizione dell’umano ingegno, che in quella camicia di forza non
bene si esprime, e inoltre contributo – nel momento in cui soffoca le capacità
innovative – all’impoverimento e al deperimento della lingua stessa che viene
imitata, suggerisce di sviluppare e ampliare il patrimonio consegnatoci da
Petrarca e Boccaccio, e dare credito ad altri autori piú recenti – sempre toscani
– come Poliziano e Lorenzo il Magnifico,
invece di ritenerli inferiori a quei sommi. Il pensiero dei due è qui alquanto
distante, e tuttavia quel che li avvicina (che vuole mantenerli avvicinati) è
il grande rimosso, il quale
occultamente sembra reggere le fila di questo discorso: se si esalta
l’innovazione e la capacità creativa e ricreativa
del letterato e del poeta, come si fa a trascurare la grande lezione offerta –
in questo specifico campo – proprio da Dante? Ed un’ulteriore sorpresa ci
attende proseguendo la lettura, quando cioè si scopre che è presente, in quella
folla di nobili anime, anche il Calmeta,
che però nella discussione sulla lingua non ha proferito verbo (!), come se la
cosa non lo riguardasse: se l’insieme degli elementi qui riportati non
configura un evidente caso di espressione coperta,
non so come altrimenti si potrebbe definire.
Ma rimozioni e coperture costituiscono in entrambi gli
autori elementi sintomatici di una scelta di costume e di civiltà considerata
in quel momento come la piú preziosa e la piú produttiva, a tal punto che anche
le divergenze individuano quel modo come
l’unico possibile per coesistere uniti, e dissentire in maniera dialogicamente
costruttiva e non polemicamente disgregativa. Se ci si sforza di rilevare elementi
comuni nei due massimi trattati del primo Cinquecento, si rimarrà colpiti nel
constatare che proprio sui temi piú caldi e delicati le cautele poste in atto
sono straordinariamente simili, e che su tutto domina la preoccupazione di
pacificare gli animi, dopo averli allertati, ma senza portarli
all’esasperazione. Per restare al Cortegiano,
la disputa sulla lingua, continuata tra Federico Fregoso e Ludovico da Canossa,
tra il fautore dell’imitazione “ciceroniana” di Petrarca e Boccaccio,
e colui il quale sta dalla parte del “pensiero” come valore determinante, di
contro alle “parole”, esaltate come qualificanti dall’altro,
viene chiusa da Emilia Pia, che ne rileva la lunghezza e la fastidiosità, e suggerisce
di rimandarla ad altro tempo.
Il tirarsi per i capelli rischia di nuocere, anche perché (soprattutto perché)
non c’è modo di conciliare due punti di vista al momento assai distanti.
Non è solo questione di bon
ton: se è vero che le cavillazioni rischiano di annoiare, è altrettanto
vero che lo scontro frontale rischia di ferire, specialmente quando non è in
grado di produrre soluzioni e alternative concrete. Lo stesso trattamento è
riservato al punto dolente della crisi contemporanea dell’Italia (come paese
intero e come singole istituzioni), che per ben due volte si affaccia nel
discorso, dà luogo ad alcune amare, talvolta pungenti considerazioni, dopodiché
si preferisce tornare alla piú distensiva dissertazione principale, quasi che
essa in sé avesse il pregio di far per lo meno diminuire il disagio quotidianamente
vissuto. Nell’un caso si replica alle deprecazioni del Machiavelli (senza mai
farne il nome, beninteso),
nell’altro si giunge a coonestare paradossalmente lo strazio inferto dagli
stranieri agli Italiani, suggerendo che la colpa è di chi subisce un processo
di decadenza senza frapporvi una reazione:
in ambedue i casi, tuttavia, il discorso accennato viene subito lasciato per
non apportare gravezza e fastidio
(e, aggiungo io, quel filo di disperazione che è sempre dotato di enormi capacità
corrosive).
Quasi il medesimo calamo sembra usato dal Bembo in uno dei
pochi passi in cui si fa menzione della crisi storica e politica in cui
l’Italia sta precipitando. Parla il Magnifico Giuliano, e auspica che l’antico
barbaro servaggio non abbia piú a rinnovarsi, per quanto gli Italiani d’allora
fin troppo si adoperino per scontrarsi fra loro, e per cedere parti del nostro
italiano patrimonio ora alla Francia ora alla Spagna;
è il mondo ch’è «guasto», e lo si vede dal fatto che ciascuno, dimentico dell’antico
valore, attenta al patrimonio altrui per goderselo da solo, né si perita, per
raggiungere tal fine, di chiamare al soccorso personale gli stranieri
aizzandoli contro il proprio stesso sangue. Lamentele fondate – commenta Ercole
Strozzi – però sterili e improduttive,
e dunque è meglio proseguire a dissertar della lingua, attraverso il quale
dibattito si ha comunque modo di affondare il coltello nella piaga, ma per
ragioni di stile e di letteratura, seguendo le quali, e pungolando “qualificati”
gruppi minoritari, si può sperare di incidere sulla coscienza degradata dei
piú. È il nucleo del discorso di Carlo Bembo. Non è la moltitudine degna di
consacrare alcunché, ma soltanto pochissimi uomini, colti e rettamente
pensanti, che non del parere della folla si curano, ma soltanto del proprio
fondato criterio di valutazione. Dunque per queste minoranze “esemplari”
bisogna scrivere, e scrivere bene, poiché esse successivamente riusciranno a
sviluppare il pensiero tramandato ed eventualmente contribuiranno anche a
diffonderlo.
Tale affermazione può essere in via di principio attenuata, ma va rilanciata
con forza ogniqualvolta il presente si sviluppi gramo e miserando, e avvenga
che quel che si trova nelle scritture degli antichi sia migliore di quel che i contemporanei
sono in grado di produrre. Tutte le volte che il passato si presenta
qualitativamente migliore del presente, ad esso bisognerà ispirarsi trascurando
la contemporaneità; per cui scegliendo di imitare il Boccaccio e il Petrarca si
può far molto meglio che seguendo l’inconsistente modello attuale,
e si sa che essi scrissero ed elaborarono meglio di chiunque altro oggi presuma
di affacciarsi alla ribalta delle lettere. Anche in questo caso, cosí come per
il Calmeta, la polemica è forte, quasi aspra, però investe direttamente il
mondo delle lettere, non la società civile, e tanto meno la struttura della corte:
semmai aggredisce frontalmente il povero Dante, e tuttavia con argomenti
fragili e non pertinenti; nell’altro caso Dante non è addirittura mai nominato dal Castiglione nel corso
di tutta l’opera sua. Per entrambi, con gli opportuni distinguo, tra chi
auspica che si riguadagnino celermente vette a suo tempo frequentate, e chi
concede qualche cosa di piú alla creatività del presente, è bene scrivere in
volgare, avendo come punto di riferimento, rigido o elastico, quello della
tradizione regolata fiorentina. E ritroviamo in entrambe le opere, quasi fosse
una specie di Leitmotiv, la
soddisfazione espressa da Giuliano de’ Medici per il tributo offerto al primato
della lingua toscana.
Non sarebbe ragionevole, afferma nel Cortegiano il magnifico Giuliano de’ Medici, in un sobrio e pacato
intervento, da parte sua impugnare l’opinione di chi celebra il primato della
lingua toscana;
e, nelle Prose, sempre il medesimo
Giuliano si dichiara comunque “soddisfatto”, quale che sia la posizione
destinata a prevalere, poiché, se “esemplare” viene proclamato il fiorentino
moderno, la centralità dell’Arno e suoi dintorni è ribadita senza titubanza
alcuna, e se anche si loda il fiorentino antico, sempre di “fiorentino” si
tratta, e l’onore in ogni caso ridonda alla “patria” sua Firenze.
Ma non è Giuliano – per l’appunto – colui che tale eccellenza esalta, né senso
forte avrebbe avuto che un Medici perorasse una causa cosí vistosamente
inclinata pro domo sua: piuttosto
risulta estremamente significativo, ed anche “politicamente” rilevante, che
siano Adria e Liguria (a suo tempo, nel secolo di Petrarca, cosí divise e
pugnaci) a convergere e a trovarsi concordi nell’additare qualcosa di profondamente
condiviso agli Italiani, tant’è vero che, nel I libro, Carlo Bembo chiama a
sostegno della sua tesi la voce di Federico Fregoso, e nel II libro è proprio
Giuliano il Magnifico a chiedere di essere sostenuto dagli esempi e dagli
argomenti di Carlo Bembo e Federigo Fregoso per seguitare a ragionare della
lingua letteraria piú confacente.
Firenze, dunque, al centro della Penisola, che attrae e governa l’equilibrio e
la concordia ideale degli Italiani, conciliando Alpi e Appennini, Tirreno e
Adriatico, senza che possa in alcun modo scattare una reazione o un’emulazione,
essendo parimenti i Fiorentini costretti a guardare, non beatamente se medesimi,
ma quel loro glorioso passato che da essi pure deve essere recuperato. Cosí
facendo, tutte le potenze italiane del tempo vengono messe sullo stesso
livello, vengono cioè perequate dalla distanza verso il passato che è uguale
per tutte, e che insieme chiama ed incita ad uno sforzo comune, in nome di quei
valori di civiltà e di cultura che altri – non gli Italiani – stanno
travolgendo, e che semmai agli Italiani spetta salvaguardare e riproporre con
severa compattezza.
Il progetto è indubbiamente affascinante, politicamente
ineccepibile, quasi “coercitivo” per le coscienze piú sensibili ed avvertite,
quelle degli intellettuali, che non a caso su siffatte posizioni si
attesteranno per qualche secolo in futuro. Resta da chiarire, però, perché
Dante in questa visione d’assieme cosí costruttiva non possa stare, e dia anzi
quasi fastidio, specie ove si tenga conto della stima e del prestigio a lui
riconosciuti – in strettissimo e ideale collegamento con le altre due “glorie”
fiorentine – fin dai primi umanisti, e segnatamente dal circolo fiorentino stretto
attorno a Coluccio Salutati, di cui dà testimonianza Leonardo Bruni attraverso
le parole di Niccolò Niccoli.
Sono fiorentini, o comunque toscani, coloro che hanno un forte interesse anche
“patriottico”, e non solo culturale, a tenere alto il vessillo della poesia
“volgare” in un contesto dove il latino è considerato la lingua “principale”,
ed è ancora un fiorentino illustre, Leon Battista Alberti, a spingere affinché
la ricchezza espressiva e poetica del volgare non vada dispersa, ma venga
ripresa ed ampliata, sia per recare giovamento ad un maggior numero di persone,
sia perché, a suo giudizio, la tradizione letteraria fino a quel punto
stratificata si dimostra ricca ed eccellente, e, pur essendo l’antica lingua
latina un serbatoio di ricchezze e occasioni espressive, non c’è motivo alcuno
per disprezzare la moderna lingua toscana. Anzi, dopo essersi assunto l’onere
di sistemare a tavolino, nero su bianco, una prima «grammatichetta» della
lingua toscana, non per caso, nella conclusione dell’opera, loda Dio per avere
avuto egli (e assieme a lui tutti coloro che ne sono interessati) la
possibilità di ricavare e ordinare i principî primi della «nostra» lingua, di
qualcosa cioè che costituisce patrimonio condiviso di una città, di una
regione, e del contributo storico dalle medesime alla civiltà elargito, e
invita, conseguentemente, i concittadini a onorare con tale mezzo la comune
patria, fidando nel fatto che il “nuovo” latino possa essere rappresentato dal
“volgare” di Toscana, del quale si può finalmente esibire una regola, che ne dimostra l’ordine e ne
attesta la solidità storica.
La prospettiva si modifica nel secolo successivo, specialmente
perché, scricchiolando non poco la situazione generale dell’Italia tutta, il
richiamo all’unità e all’armonia di intenti passa anche attraverso una precisa
proposta di impegno culturale, che veda al centro dell’attenzione, delle cure,
e dell’onore comune non piú una singola “patria”, che pacificamente compete con
le altre, ma l’intera nazione italiana, ovverosia quel tessuto fitto di
intrecci culturali, politici, storici e civili, che copre quel che Dante
chiamava «giardin de lo ’mperio»
e Petrarca con eleganti versi latini definiva «chara Deo, tellus sanctissima».
Si può tranquillamente dire che sono non‑fiorentini coloro che con
maggior forza si fanno carico di tale problema, e che sono con grande proprietà
ritratti sia nelle Prose che nel Cortegiano, e tuttavia ad un fiorentino
si rivolgono, e perché appartenente a prosapia illustre, per meriti politici ed
anche culturali, nonché parente di ben due papi (e cruciali entrambi: Leone X e
Clemente VII) da quella casata espressi, e soprattutto perché sarebbe
impensabile, in un processo di cosí alta ricomposizione, fare a meno di
Firenze. Forse proprio qui sta la chiave del problema, nel senso che
riconoscere il magistero dei Fiorentini e considerarli come la fucina ideale
per temprare il linguaggio delle lettere, deve comportare che i Fiorentini
medesimi si riconoscano in detta fucina, vi si muovano a proprio agio, e non giungano
mai ad avvertirla come possibile labirinto di inghippi ed inganni. La cosa si
renderebbe possibile – addirittura probabile – qualora, come parte integrante
della lega da malleare, fosse accreditato anche Dante, in quel frangente
storico soprattutto.
Lumi derivano dalla lettura del Discorso del Machiavelli, del quale è nota l’enfasi “petrarchesca”
posta a suggello delle pagine finali del Principe,
mentre a supporlo affine per temperamento e carattere al grande «Exul immeritus», saremmo certamente nel
giusto, ma sbaglieremmo ad estendere queste affinità anche al gusto letterario,
condizionato da ben precise – e diverse
– scelte politiche e patriottiche.
Per chiarire: la tradizione del “patriottismo letterario” fiorentino
non si attenua affatto nel Cancelliere, e tutta l’opera presa in esame si muove
all’insegna dell’esaltazione di una leadership che sola Firenze in Italia può
vantare, considerato che le provincie rilevanti sono non più di cinque (Lombardia,
Romagna, Toscana, Terra di Roma e Regno di Napoli), caratterizzate da favelle assai
diverse,
sprovviste di una degna tradizione letteraria (al punto che anche letterati
provenienti da quelle terre usano il toscano perché migliore e piú acconcio
alla scrittura),
addirittura talvolta contraddistinte da un parlare barbaro che rasenta la bestemmia.
Non spira irenismo da queste pagine del Machiavelli, e si comprende anche da
ciò il motivo di una famosa “esclusione”. Nondimeno, nel momento in cui è
proteso nello sforzo di ribadire una posizione di preminenza, quando si rifà
agli esordi delle nostre lettere è d’obbligo per lui richiamare le famose tre
Corone
come vertici di uno sviluppo messo in movimento da scrittori essenzialmente
“fiorentini” (con l’eccezione di un bolognese, un aretino e un pistoiese).
Quell’operazione di forgiatura della lingua è stata possente, a tal punto che
coloro i quali vogliono seguitare in tale lavoro, per onorare quell’idioma che
essi coltivano e amano, debbono seguitare a plasmare in fiorentino i
forestierismi, riconoscendo tuttavia che la loquela che cosí viene arricchita
ed innovata sempre fiorentino rimane
e non diventa per questo lingua altra:
su questo si articola principalmente il dialogo simulato con Dante, per
costringerlo ad ammettere che quella benedetta lingua “curiale” di cui fa cenno
è in realtà fiorentino puro, non cortigiano.
Su questo aspetto sembra concentrarsi l’intero dibattito, a sostegno di quella
tesi – discussa e rigettata dal Bembo, ed anche dal Castiglione – che vede con
favore il fiorentino parlato, quindi vivo e “contemporaneo”, come base per
qualunque elaborazione letteraria vogliano fare gli Italiani di qualunque
contrada. E tuttavia, pur volendo far tralucere la “fiorentinità” di Dante, a
maggior gloria della comune patria Firenze, proprio su alcuni aspetti
tutt’altro che secondari Machiavelli appunta le sue critiche ed i suoi strali.
Poiché Boccaccio afferma esplicitamente di aver composto in
volgare “fiorentino”, e Petrarca non si è mai pronunciato in proposito,
essi non debbono essere discussi, essendo l’uno dichiaratamente fiorentino e
l’altro “neutrale”;
su Dante però, che sostiene di aver usato una lingua “curiale”, merita
soffermarsi: e con il pretesto della questione linguistica fioccano le censure. Pur riconoscendo esser egli
stato quasi in ogni sua cosa uomo eccellente, per ingegno, cultura, gusto, gli
rimprovera ciononostante di aver mancato gravemente nei confronti della patria
sua, ingiuriandola, infamandola, sparlando di lei e dei suoi cittadini; e non
limitò le sue offese a qualche parte isolata della Commedia, ma la infarcí tutta di spirito di rivalsa e di
contumelie, tanto si ritenne offeso dal verdetto dell’esilio, e tanto per
l’intera sua vita perseguí il sogno di una vendetta. Firenze – giunge a dire
Machiavelli – ha davvero allevato una serpe nel suo seno; e tuttavia la sorte,
che benignamente l’ha fatta prosperare, ha smentito le calunnie di quel suo pur
illustre cittadino, e ha messo a nudo le sue menzogne, tanto che ora essa è la
piú celebre delle province cristiane, a disdoro di quel figlio ingrato che, per
portare all’estremo l’ingiuria alla sua patria, volle persino rinnegare la
lingua nativa, sforzandosi di dimostrare che non fiorentina era la favella che
sosteneva il suo elevato stile. A ciò abbassandosi, Dante ha infirmato la sua
stessa costruzione, e poco credito finiscono con l’avere le sue “trovate”, come
i Fiorentini condannati tra i ladroni, Bruto in bocca di Lucifero e persino
Cacciaguida nel Paradiso: insomma, le colpe di Dante verso Firenze sono gravi a
tal punto da farlo ritenere un mentecatto, degno di essere espulso.
Non si tratta di impeti stravaganti dettati da cattivo umore. Tutta l’opera è
ispirata da amor patrio, tant’è vero che ciò è proclamato chiaramente fin
dall’esordio, nel quale un rilievo adeguato meritano coloro che hanno il torto
di rivoltarsi quando dalla patria patiscono ingiustizie e affanni. Per quanto
da essa possa essere stato offeso, chiunque nel sentimento e nelle azioni opera
contro la patria sua può a buon diritto essere definito “parricida”. Nefasta
cosa è non onorare o addirittura il battere la propria madre e il proprio
padre: è pertanto cosa sciagurata ledere la propria patria, dalla quale mai si
patisce offesa tale da meritare risposta tanto colpevole. È inoltre la patria
colei che ti definisce e ti sostiene, e, quand’anche decida di esiliarti (il
che può capitare), sempre somma è la riconoscenza che a lei devi, perché sacra
a te deve essere quanto sacro è Iddio, e la sua difesa contro ogni nemico o
detrattore è dovere supremo, civile, morale e religioso.
Da questi forti e “sacrali” presupposti scaturiscono le critiche, non personali
ma patriottiche, rivolte a Dante, il quale piano piano finisce per diventare quasi
il nemico primo di Firenze, tanto materiale ha accumulato – nella sua pur meritoria
opera – per fornire di miccia i di lei avversari. E la questione delle “cadute”
nelle asprezze del parlato appare qui con palese evidenza: non si tratta – per
il Machiavelli – di alternanze di stile, si tratta di vere e proprie macchie
che deturpano la patria, perché le oscenità, che pure Dante non si è
risparmiato, disonorano l’intero poema, gettando infamia anche sul parlar
materno, che per l’appunto è fiorentino.
Quale che sia la data di composizione del Dialogo,
è da presumere che esso rifletta opinioni e giudizi in Firenze circolanti. Stando
cosí le cose, è evidente che, per mantenere un equilibrio in cui anche i
Fiorentini potessero fare la propria parte, era necessario che qualunque arma
contro di loro venisse preventivamente spuntata: era cioè necessario espungere
Dante dal canone letterario, poiché i suoi concittadini per primi, in quel
clima teso di forti rivalità e competizioni (per l’egemonia, per le contese
territoriali, per il Papato), avevano ritenuto conveniente ripudiarlo. Né desta
la cosa meraviglia, se si ricostruisce, anche solo in parte, il fitto mosaico
di contrapposizioni che hanno marchiato la cruenta storia d’Italia dopo la
calata di Carlo VIII e i primi decenni del Cinquecento, contrapposizioni nelle
quali ognuno ha la sua parte, e non piccolo è il ruolo ricoperto – fra gli
altri – oltre che da Firenze, anche da Venezia e Genova (i cui portavoce
animano da protagonisti, non per caso, le opere di cui qui ci si occupa).
L’inimicizia tra Firenze e Venezia è un fatto che già
insanguina la politica italiana prima del 1505, quando Ercole d’Este riesce a
portare a termine una mediazione, per altro non risolutiva né foriera di futura
pace.
Ma le manovre delle potenze italiane si intrecciano perversamente anche con le
battaglie che i Fiorentini debbono sostenere per mantenere la supremazia sulla
Toscana, scontrandosi con Pisani e Lucchesi, dietro i quali si erge l’ombra
minacciosa di Genova,
e ancora con i Senesi, dai quali li divide un «odio antico».
Né le fortune dei Medici – piú italiane
che fiorentine, almeno fino agli anni ’30-40 – costituiscono salvaguardia o
usbergo sufficiente, semmai rappresentano un pericolosissimo innesco di
potenziali aggressioni, qualora le sorti in Roma cangino per leggi naturali, e
l’eventuale successore di un papa Medici abbia in animo di presentare alla
patria del pontefice defunto il conto per le operazioni di nepotismo portate
dal predecessore a buon fine.
E ancora nel 1529 la pace da poco conseguita è considerata un bene per tutta
Italia, ma un male proprio per Firenze.
Per quanto noi si abbia una visuale dei fatti – considerati storicamente
rilevanti – diversa, gli uomini di allora con queste mosse si misuravano sulla
scacchiera d’Italia, considerata comunque ancora il centro della cattolicità; e
il verminaio scoperto da Carlo VIII, con i Veneziani impugnati da quasi tutti
gli altri potentati d’Italia,
avrebbe seguitato a brulicare negli anni a venire, quando «crudelissimi
accidenti, infinite uccisioni, sacchi ed eccidi di molte città e terre»
avrebbero steso un pesante velo di empietà e di incapacità politica
sulla sorte della penisola tutta, e nemmeno i papi (passi per Giulio II,
ma addirittura il supremo mecenate Leone X)
sarebbero riusciti a sottrarsi alla logica perversa della violenza e
dell’eccidio, contribuendo, da par loro, a esacerbare e squilibrare gli animi e
le coscienze.
Dopo questa rapida, e necessariamente sommaria, ricognizione
storica, si capisce meglio quanto fosse costoso, ma altresí necessario, il
parlar coperto di Castiglione e di
Bembo, e insieme perché tanto l’uno quanto l’altro, dopo un breve
ma incisivo accenno ai mali della contemporaneità, portino gli interlocutori a
parlar d’altro. Il mondo era «guasto», ed era sufficiente il menzionarlo,
grondando un po’ quasi tutti gli Italiani di ferite inferte da fraterna mano. Se
gli uomini – scrive il Bembo negli Asolani
– avessero l’animo altamente proteso verso i valori eterni, il vivere sarebbe
molto piú dolce e piú bello di quello che invece risulta nel momento in cui le
cure del corpo (cosí riscontrava in quei frangenti) sovrastano quelle
dell’anima, rendendoci meno degni della nostra umanità.
Solo pensando ai valori “veri”, celesti e non caduchi, ci si trova completamente
appagati, perché nell’oltremondo mancano tutte le miserie e i crucci terreni,
mancano le meschine rivalità proprie dei mortali, nessuno è a rischio di
assalti o di congiure, domina la lealtà e la tranquillità, specie quando arra è
fornita da Colui che è amore eterno, eterna pace, eterna serenità.
Viceversa in terra egoismo e insaziate brame di onori e di potere sconvolgono
il mondo, rompono gli umani equilibri, affogano i vincoli umani nel sangue
fatto scorrere a fiumi, spettacolo purtroppo assai ricorrente in quell’“aureo”
secolo, dominato da scontri di sovrani incapaci di pensare se non alla potenza
personale.
Se si conducesse la vita con l’animo volto all’eterno, quasi con il riso sulle
labbra si sopporterebbero le angustie e i mali terreni, e l’alternanza di
glorie e di rovesci sarebbe agevolmente sostenuta con animo temperato e
tollerante.
Questo richiamo alla pace e alla concordia, completato nelle Prose, si sforza in sommo grado di
contrapporre agli imperativi dominanti del fratricidio e della congiura una
logica altra, che ritessendo i rapporti, “culturali” in primis, ma poi politici fra gli italiani di qualità, additi
soprattutto i motivi e gli strumenti di unione, senza escludere nessuno,
soprattutto senza escludere coloro che della civiltà italiana sono stati i
costruttori primi, e cioè i toscani con Firenze al centro. Se Dante viene, dai Fiorentini
per primi, visto come strumento del nemico (e si pensi a quel che potevano farne
i Pisani, i Senesi, i Lucchesi, a tacer d’altri), a malincuore, ma per un
principio cogente di necessità, è opportuno stendere su di lui un velo, anche
perché il grande poeta “civile” della conciliazione tra gli Italiani è stato
proprio Petrarca, non Dante, il cui giustizialismo di fondo ha impregnato di
aggressività (non priva, per altro, di giustificazione) il suo immenso poema quasi
tutto. Ebbene, le numerose invettive da Dante scagliate contro Firenze, ma
anche contro l’Italia, e contro il Papato e l’Impero … in quel momento storico
rischiano di “arrogere” danno a danno, e di fornire, sia agli Italiani sia agli
stranieri, potenti strumenti per incrementare odi e divisioni.
Non si deve dimenticare, inoltre, che i potentati italiani hanno, e sentono di
avere, un ruolo ancora fondamentale sull’intero scacchiere europeo: l’oceano Atlantico
non è al momento divenuto il bacino principale degli scambi economici, Venezia
è tuttora la prima potenza marinara della Cristianità (e Lepanto rappresenterà
il suo trionfale canto del cigno), Roma continua ad essere al centro di un
intero universo, le cui corrosioni si stanno allargando, ma non al punto da
rivelarsi crepe. Per un paio di secoli, fino al brusco risveglio ottocentesco,
tale sarebbe rimasta la coscienza di sé che avrebbe animato gli spiriti
italici, e linfa vitale avrebbero tratto proprio da Petrarca. Successivamente, dopo
la pace di Vienna, divenuta la maggior parte della Penisola un insieme di
protettorati minori di un’unica grande potenza europea, gli animi si sarebbero
eccitati per un risveglio e un’azione compatti e aggressivi, e a quel punto
Dante sarebbe stato richiamato in servizio alla grande.
Questo, però, è un problema diverso, che ha bisogno di tempo
(parecchio) per giungere a maturazione.